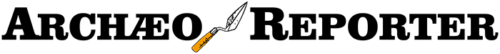Nella sua definizione più semplice e semplicistica, l’attività di fundraising è indicata dal “Cambridge Dictionary” come: the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity. (L’azione di raccogliere o produrre denaro a favore di una specifica causa, e in particolar modo a favore di un ente benefico).
Nonostante le numerosissime varianti accademiche, l’intera storia recente del fundraising in ambito culturale ha seguito, con le dovute eccezioni, questo tipo di interpretazione del fenomeno.
Si tratta, tuttavia, di una interpretazione che è destinata inesorabilmente a sparire dal nostro scenario. Ad un’analisi un po’ più attenta, infatti, ciò che più colpisce delle pratiche applicative associabili a questa interpretazione del fundraising è il numero di cose che semplicemente vengono date per scontate.
In primo luogo, si dà per scontato che, in un dato momento e in un dato contesto sociale, ci siano sufficienti persone che hanno la disponibilità economica e la disponibilità a fornire risorse. Questa condizione è tutt’altro che assiomatica e dipende da numerose circostanze, che variano dalla distribuzione di ricchezza all’interno del territorio fino al numero di organizzazioni che si occupano di raccogliere le donazioni per specifiche cause.
Questo ci porta alla seconda ipotesi, che viene assunta come certa e che invece, nella pratica rappresenta una condizione tutt’altro che frequente: la presunzione che non ci sia una sostanziale “concorrenza” tra le grandi cause. Pur assumendo che tutti i cittadini di una data nazione abbiano a disposizione e vogliano contribuire a temi di rilevanza collettiva, l’esplosione di una pandemia, ad esempio, algebricamente andrà a veicolare parte di tali risorse al comparto sanitario, riducendo quindi le somme disponibili per gli altri comparti.
Ulteriore elemento da considerare, tutt’altro che marginale, è che l’inclusione della cultura tra le grandi cause si contrappone ad una sempre più diffusa interpretazione della cultura come comparto produttivo in grado di partecipare attivamente allo sviluppo anche economico della nostra società.
In altri termini, presupposto del fundraising culturale svolto in modo tradizionale, è che la cultura necessiti di “donazioni” per essere sviluppata. Condizione che è invece contrasta in modo evidente con le dichiarazioni che, dall’Unione Europea al nostro ministro Franceschini, vedono il comparto delle Industrie Culturali e Creative una “leva” trainante del sistema produttivo nazionale e comunitario.
Chiaramente, questa contraddizione in termini è facilmente risolvibile: i segmenti produttivi che ad oggi vengono ricondotti al cluster delle ICC sono talmente eterogenei da ricomprendere all’interno dello stesso paniere esperienze che senza interventi pubblici o donazioni private non potrebbero nemmeno sussistere con aziende e brand in grado di generare profitti considerevoli, dal cinema all’alta moda, passando, talvolta, anche per le big-tech.
Classificazione chiarissima per le imprese del settore, meno chiara, forse, per quegli interlocutori che da anni vengono coinvolti in qualità di donatori e che oggi invece auspicherebbero all’affermazione di una nuova modalità di partecipazione.
E’ su questo ganglio che è dunque opportuno iniziare a costruire una nuova forma di fundraising culturale, cercando di ridurre al minimo il numero di azioni culturali non sostenibili ed incrementando attività che, oltre ad avere una propria desiderabilità sociale, siano in grado di sviluppare economie, non solo per l’organizzazione che effettua la raccolta di capitali, ma anche per il territorio in cui le azioni vengono condotte.
In questa logica, pertanto, più che di donazioni, il fundraising culturale dovrebbe occuparsi di promuovere azioni di “investimento sociale”, per finanziare progetti che abbiano una loro sostenibilità interna, ma che, per quelle tipicità che spesso caratterizzano le dimensioni culturali e creative, richiedono un tempo di realizzo pluriennale.
Con tale tipologia di “partecipazione”, in altri termini, il soggetto non “donerebbe” il proprio denaro, ma rinuncerebbe al maggior profitto che tale denaro potrebbe fruttargli qualora venisse investito in azioni profit.
Differenza che può sembrare sottile, ma soltanto dal punto di vista “teorico”. Praticamente, un approccio di questo tipo semplicemente rivoluzionerebbe il fundraising.
Cambierebbero, ad esempio, i rapporti tra le parti: il potenziale donatore, ora finanziatore, non potrebbe di certo essere coinvolto soltanto nelle fasi monetarie: vorrebbe comprendere meglio il progetto, le ambizioni sociali che persegue, i meccanismi di gestione, il team di lavoro, e le modalità attraverso le quali il team intende perseguire la sostenibilità del progetto in un dato intervallo di tempo.
Questo comporterebbe una più stretta relazione tra finanziatore e organizzazione, condizione che abiliterebbe lo scambio di informazioni, di visioni, di competenze, oltre che di mero denaro.
Comporterebbe altresì un tendenziale incremento qualitativo e manageriale dei progetti coinvolti: se la “causa” basta a sé stessa in un’operazione di donazione semplice, non è altrettanto vero in una operazione di investimento. Questa condizione tenderebbe, per il meccanismo della concorrenza, a sviluppare sempre più competenze all’interno del settore.
La creazione di progetti culturali sostenibili nel tempo, poi, migliorerebbe il generale set d’offerta di servizi offerti sul nostro territorio: ove ora c’è un pullulare di progetti annuali che dopo un anno affievoliscono fino a svanire, emergerebbero organizzazioni in grado di crescere sul territorio, e così coinvolgere sempre più cittadini, e sempre più istituzioni.
In questo scenario, sarebbero poi le stesse organizzazioni ad approfondire con attenzione i criteri di sostenibilità: non è infrequente incontrare organizzazioni che hanno raccolto, attraverso bandi o finanziamenti privati, somme molto ingenti di denaro, e che poi non hanno tenuto conto delle reali economie del progetto presentato.
Quante organizzazioni hanno esultato per l’aggiudicazione di un bando europeo, per poi accorgersi, una volta ultimato, che il progetto ha generato più uscite che entrate.
Di fronte a tali trasformazioni cambierebbe poi inesorabilmente la figura del fundraiser, con la progressiva affermazione di professionisti sempre più “specializzati”, con competenze di project management, e di finanza, con conoscenze del settore culturale e con abilità di networking.
Risorse, con queste caratteristiche, cambierebbero infine la struttura del mercato nel suo complesso, rendendo impossibile per un’Amministrazione richiedere una figura di fundraiser che lavori solo su success fee, come la recente vicenda che ha visto protagonista il Teatro Lirico di Cagliari, e, allo stesso tempo, garantendo una equa ripartizione tra retribuzione fissa e quota di retribuzione sulla base dei risultati raggiunti in termini di raccolta di investimenti, incentivando quindi la capacità del soggetto di creare e soprattutto, mantenere stabili nel tempo i propri progetti culturali.
Un cambiamento che, è bene evidenziarlo, combinerebbe la sostenibilità tipica dell’investimento dei progetti di investimento con le motivazioni sociali che invece sono proprie della donazione e che, in questo senso, potrebbe essere una leva che se opportunamente stimolata anche da parte del settore pubblico e fiscale, potrebbe risultare estremamente efficace per ridurre il così tanto elevato livello di risparmio aggregato del nostro Paese, senza andare a ridurre quelle disponibilità che gli italiani già destinano alle grandi cause, ivi inclusa quella “culturale”.